30/04/2020
Apri la versione pdf o scarica gli ebook epub/mobi/pdf (zip).
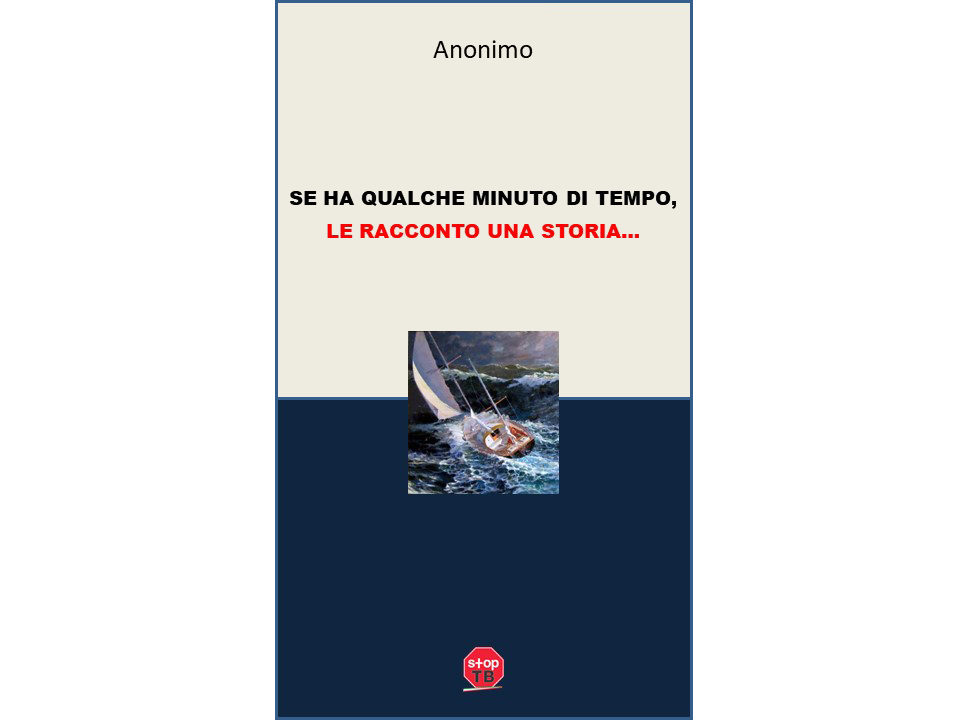
Sono un medico, ogni giornata lavorativa mi mette in contatto con un’umanità varia, per lo più sofferente, ma che sempre porta con sé delle storie, le quali, talvolta, da anamnesi routinarie si trasformano in narrazioni di vita, interessanti da ascoltare come la vicenda che mi accingo a riportare. Ringrazio la persona che mi ha raccontato la sua storia con sapiente affabulazione, facendo in modo che la ricordassi nel tempo.
Alcuni anni fa mi trovavo in reparto e stavo lavorando a una relazione sull’approccio alla TBC in Pronto Soccorso. Avrei dovuto presentarla entro pochi giorni a un congresso.
Si affacciò sulla porta dello studio medico una paziente, chiedendo educatamente se sapevo a che ora sarebbe stata dimessa il giorno dopo. Era una donna di bell’aspetto, non più giovane, alta e magra, con un sorriso timido, ma accattivante. Stranamente la sua interruzione non mi fece irritare, come di solito mi capita in situazioni simili e la feci entrare. Si dimostrò interessata e competente rispetto all’argomento che stavo trattando e quando le chiesi dove avesse acquisito tutte quelle conoscenze, si accomodò su una sedia e pronunciò sorridendo una frase che su di me ha sempre avuto un effetto ‘calamitante’: “Se ha qualche minuto di tempo, le racconto una storia…”.
Voglio iniziare il mio racconto con una metafora così capirà meglio il significato che questa vicenda ha avuto per me e per la mia vita: narrerò la storia di una piccola barca dotata di un timone e di una sola vela, che in mezzo al mare viene travolta dalla tempesta. Dopo molte difficoltà il tempo cambiò, il timone rimase saldo e l’approdo fu accogliente.
È la storia di una rigenerazione fisica e psicologica che passa attraverso la malattia: degenerazione del corpo che riesce a produrre nuova consapevolezza della mente e il risveglio di sentimenti.
È la storia di una primavera che ritorna per consentire a un terreno martoriato dalle intemperie della brutta stagione di riprendere la sua vitalità, i suoi colori, la sua energia. Avevo poco più di venti anni e mi trovavo in un serio disagio esistenziale a causa di un percorso universitario a indirizzo scientifico, faticoso, scelto non proprio volontariamente, più per convenienza che per passione.
Ci mettevo tutta la volontà di cui ero capace ma indubbiamente i miei interessi erano di tutt’altro tipo: meno tecnici, meno realistici, più fantasiosi.
Mi aggrappavo al mio dovere pensando solo allo studio, alla necessità di sostenere gli esami in tempo utile; cercavo di non pensare a quella che era la mia reale inclinazione, evitavo di guardarmi intorno per non intristirmi e per non distrarmi dal mio impegno, mi impedivo di ricordare la serenità e le speranze degli anni che avevano preceduto questa infelice scelta di studio.
Dopo un paio d’anni di questa vita, una subdola fatica cominciava a impossessarsi di me, talvolta la sera comparivano tre-quattro linee di febbre che io percepivo, ma facevo finta di niente: ingoiavo un’aspirina e tutto passava fino al giorno dopo. Andai avanti così per alcuni mesi, sempre triste, con quella stanchezza e quella febbricola a cui si era aggiunto un mal di schiena trafittivo che attribuivo alla posizione coatta di studente alla scrivania. Cercavo di resistere, cambiavo spesso posizione, frequentavo un paio di ore la settimana la piscina per rinforzare la muscolatura dorsale: una radiografia del rachide e anche una dei polmoni non evidenziavano problemi in atto, salvo qualche linfonodo calcificato. La situazione già gravosa, peggiorò drammaticamente quando iniziai il percorso pratico del mio corso di studi; scelsi un po’ casualmente un indirizzo che non mi appassionava più di tanto ma mi dava l’opportunità di frequentare insieme a qualche volto noto, conosciuto durante le lezioni e quindi mi sentivo meno sola. Dopo pochi giorni mi resi conto di essermi cacciata in una tana di lupi: divenni oggetto di un sottile, ma percettibile maltrattamento quotidiano, sembrava che ogni mia iniziativa e ogni mio movimento fossero errati e soprattutto inadeguati. Non trovavo giustificazione per questa palese antipatia nei miei confronti: ero solo una tra i tanti, perché venivo trattata con tanta sufficienza? Evidentemente esprimevo insicurezza e smarrimento, caratteristiche che in un ambiente di rampanti suscitavano solo fastidio e irritazione. Fu il colpo di grazia per la mia incertezza di fondo e per la scarsa fiducia in me stessa che avevo accumulato in quegli anni in cui avevo vissuto con la sensazione di percorrere una strada sbagliata. Cominciai a dimagrire, la sintomatologia che già accusavo aumentò di intensità, la notte dormivo con un asciugamano a portata di mano perché mi svegliavo fradicia di sudore. Finalmente ad aprirmi gli occhi e a interrompere questo sfinimento fisico arrivò un sintomo fastidioso e insistente: la tosse. La cosa più ovvia da fare quando hai una tosse che non ti dà tregua è una radiografia del torace. Quando conobbi il referto mi venne quasi da ridere, un riso amaro: dopo tutto questo patema d’animo ero riuscita a ridurmi inconsapevolmente alla stregua di un personaggio di un romanzo ottocentesco: consunta, sfortunata e a rischio di essere condannata dalla pubblica opinione, anche se la causa del mio male non era la povertà, non era un ambiente insalubre, non era la fatica fisica, bensì un incontenibile sfinimento psichico. Fu proprio il radiologo refertante che, preoccupato per il referto polmonare, con premura e sollecitudine mi indirizzò da un bravissimo medico suo conoscente. Il dottore era tecnicamente molto preparato, pratico e privo di pregiudizi. Sommariamente gli raccontai la storia, senza dilungarmi nei particolari che mi sembravano inopportuni, ma ebbi la sensazione che avesse comunque intuito il disagio in cui mi trovavo.
Mi organizzò il ricovero e io potei infilarmi finalmente sotto le lenzuola di un letto di ospedale e, nonostante la situazione fosse tutt’altro che rassicurante, fu come togliermi un macigno dal cuore: finalmente potevo smettere di preoccuparmi e di arrovellarmi perché ero giustificata dalle circostanze e perché qualcuno si sarebbe occupato di me.
Non aria fresca, non passeggiate salutari, ma solo uno splendido isolamento che mi consentiva di riacquistare energia tra le quattro mura di una linda stanza di ospedale.
Quando mi sentii meglio e fu scongiurato il rischio di contagio, cominciai a muovermi attraverso i corridoi di quel nosocomio dove conobbi molte persone con problemi analoghi al mio, per le quali la sopravvivenza quotidiana era sicuramente prioritaria rispetto alla dimostrazione di supremazia intellettuale con la quale avevo dovuto combattere fino a quel momento.
Il riposo forzato, le giornate tutte a mia disposizione e le terapie ebbero un effetto rigenerante: risposi molto bene al trattamento, recuperai forza ed energia fisica e mentale e dopo due mesi di tregua ripresi a studiare, riuscendo a superare un paio di esami non troppo pesanti.
Purtroppo il tormento non era finito: il piano di studi mi costringeva a completare il percorso pratico nello stesso ignobile luogo dove l’avevo iniziato. Poiché stavo meglio, mi sentivo un po’ più fiduciosa e rinfrancata e così, con cauto ottimismo, ripresi il mio tirocinio.
Dopo due settimane di frequenza ero nuovamente precipitata nello sconforto e nell’angoscia: le persone e i comportamenti erano immutati. Mi fu finalmente evidente che in quel posto ero indesiderata, ma come potevo uscire da questa trappola, se ormai mi ero impegnata a frequentare proprio lì? Un’amica alla quale avevo esternato questo ostacolo esistenziale commentò un po’ sovrappensiero: “Che brutta situazione, l’unica cosa che potresti fare è provare a cambiare…”. Pensai che questo verbo negli ultimi quattro anni fosse stato rimosso dal mio vocabolario e anche dal mio cervello. “Voce del verbo cambiare”: ma come mai prima d’ora non mi era mai venuta in mente questa possibilità? Perché mi ero ridotta a considerare la mia condizione ineluttabile? Dove stava scritto che quel percorso di studi doveva essere definitivo come una condanna?
Mi precipitai presso gli uffici dell’Università dove mi confermarono che non c’erano problemi ad effettuare un cambio di sede, a condizione di avere una proposta alternativa.
Inebriata da questa luce in fondo al tunnel, la mia mente elaborò anche il passaggio successivo: contattai il dottore che mi aveva curato e che tutt’ora mi stava seguendo e gli chiesi se secondo lui potevo continuare il tirocinio presso la struttura dove ero stata assistita poiché disponeva di tutti i requisiti necessari: in questo modo il mio iter di studio non si sarebbe discostato troppo da quello intrapreso in precedenza.
La sua intelligenza di uomo e di medico fu grande: in quei mesi di cure aveva compreso la mia condizione di difficoltà e i rischi che essa comportava per la mia ancora fragile salute e la sua risposta fu affermativa. Tale disponibilità fu per me la terapia più efficace del mondo.
Finalmente mi sentii libera e con le idee più chiare: non ero più succube della situazione. Avevo trovato una collocazione in un ambiente più umano e sereno che mi avrebbe consentito di terminare con maggiore consapevolezza e convinzione gli studi. Soprattutto avevo compreso che ero stata ottusa a ignorare i segnali del mio corpo pensando che fossero in subordine rispetto a un obiettivo di vita quale il conseguimento di una laurea, ma alla fine era stato proprio il male fisico a fermarmi, a costringermi a ripensare la situazione e a indurmi a trovare una soluzione.
Galvanizzata dalla mia nuova condizione di riacquistato benessere fisico e mentale finii decorosamente i miei studi e mi addentrai nel mondo del lavoro. Gli anni si susseguirono per strade più in salita che in discesa, ma senza grossi scossoni. Tuttavia per me il capitolo TBC non era stato completamente archiviato, perché, come diceva un illustre professore, “il bacillo di Koch non muore mai” e infatti a distanza di tempo, in una fase un po’ difficile della mia vita, ebbi una recidiva. Questa volta fui lesta a riconoscere i segnali, ma il decorso clinico fu complicato dagli effetti collaterali dei farmaci. È stato un periodo faticoso perché non ero più giovanissima e la sintomatologia si presentava alquanto invalidante. Per fortuna l’esperienza clinica di chi mi ha seguito in questa ricaduta, mi ha consentito di venirne nuovamente fuori. Oggi mi trovo qui a causa di una febbre elevata che si è protratta per più giorni nonostante la terapia antibiotica. Mi sono molto preoccupata in considerazione dei miei trascorsi clinici, ma dagli accertamenti effettuati pare che sia tutta colpa di un virus: questa volta il micobatterio non c’entra e domani potrò tornare a casa mia. Dottoressa, come vede, casualmente la sua relazione per il congresso si è innestata sulla mia storia personale. Grazie per avermi ascoltata, ma non voglio disturbarla oltre. Però, mentre parlavo ho sbirciato le sue diapositive: non si offenda se le dico che sono troppo scritte e un po’ monotone. Deve snellirle e renderle più vivaci. Inoltre ha omesso di fare quella conclusiva con la classica frase “Grazie per l’attenzione”. Mi permetto un suggerimento: per tipizzarla, nell’angolo in alto a destra ci metta la foto del dottor Robert Koch”.
Seguii il suo consiglio.
Torna a tutti i racconti