30/04/2020
Apri la versione pdf o scarica gli ebook epub/mobi/pdf (zip).
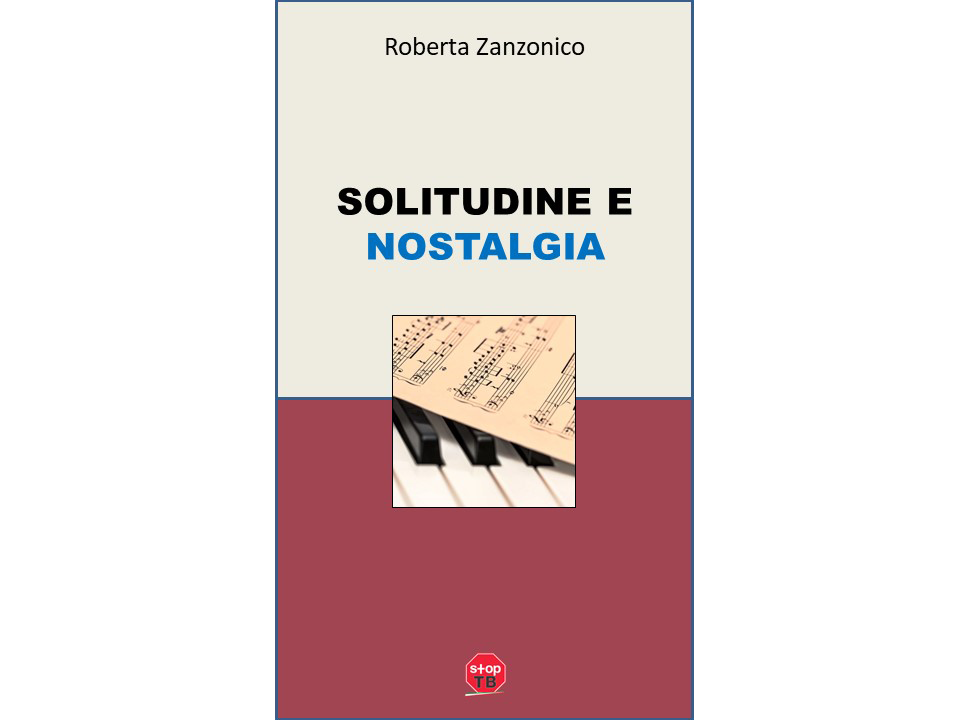
La sera sentiva una febbre leggera salire per poi abbandonarlo di nuovo lasciandolo coperto di perle di sudore. Gli era passato l’appetito e il corpo, di base longilineo e sottile, era lentamente cambiato in un groviglio di ossa, pelle e tosse. Fu solo quando cominciò a tossire sangue che si decise ad andare in pronto soccorso. Nel percorso verso l’ospedale si rese conto di quanto fosse diventato debole: a malapena riusciva a camminare, gli mancava il fiato e si accasciò a terra un paio di volte prima di riuscire a raggiungere l’entrata del pronto soccorso. Non parlava la lingua, ma aveva fatto capire chiaramente al medico di turno che tossiva da tanto e che da poco tossiva anche sangue. Aveva avuto paura di essere deportato, di dover pagare soldi che non aveva, e così aveva aspettato. Nel frattempo, il micobatterio si era preso i polmoni, aveva scavato al loro interno e ora si affrettava a disseminare in tutto il suo corpo. Ricordava la tosse dei suoi compagni di viaggio sull’imbarcazione sovraffollata che lo aveva portato sulle coste italiane.
Nemmeno il tempo di respirare quella nuova libertà che già si era ritrovato scheletrico e quasi morente nel reparto di infettivologia. Si era chiesto cosa ne fosse stato degli altri, soprattutto dei bambini e delle loro madri, se fossero sopravvissuti a tutto, anche alla tosse. Non fu sorpreso quando i medici gli dissero che aveva la tubercolosi. Sua madre era morta di tubercolosi. Lui non la ricordava, ma ricordava le storie sulla mamma morta e sulle altre persone del suo villaggio uccise dal micobatterio. Qualcuno però si era ripreso, allora si ripeteva in mente le storie di sopravvissuti sperando così di salvarsi anche lui.
Si trovò in una stanza di ospedale dove solo medici e infermieri con i volti coperti dalla mascherina venivano a fargli visita. Provava a capirne le espressioni nascoste: erano preoccupati? Speranzosi? Aveva in questo modo cominciato a decodificare emozioni dalle rughe della fronte e dai battiti di ciglia, convincendosi di aver imparato il linguaggio segreto dei volti coperti. Nonostante fosse solo in quella stanza, era certo che ci fossero altri malati come lui. Lo sapeva perché ne sentiva la tosse giungere dalle stanze accanto, che suonava così simile alla sua. Rimaneva spesso con le orecchie in ascolto, per sentire se gli altri sconosciuti con la tosse si erano ripresi, se peggioravano, o se morivano. Poco importava che non capisse la lingua.
Ero una studentessa di medicina dal volto coperto da una mascherina, quando entrai nella sua stanza, seguendo lo sciame di persone dietro il primario. Era rimasto in silenzio, mentre il primario aveva auscultato i polmoni e fatto domande al medico di turno. Aveva gli occhi tristi, non capiva le conversazioni tra medici, e nessuno ebbe la premura di tradurgli le comunicazioni inintelligibili che avvenivano davanti a lui. Fu così che tornai nel pomeriggio chiedendo in inglese come stesse e se avesse domande da porre. Lui sembrò sorpreso di poter finalmente parlare nella sua lingua: chiese se stesse morendo; domanda a cui non fui sicura di poter dare risposta, quindi parlai per percentuali, sperando che la conversazione si spostasse su altro. Allora raccontò del suo villaggio e delle storie della gente sopravvissuta e della mamma che era morta. Raccontò storie della sua vita, che ora sembrava così fragile e diafana, affidandole a me in modo che almeno qualcuno ricordasse che in quella stanza di ospedale c’era stato, una volta, un uomo che aveva vissuto.
Nei giorni successivi, mi ritrovai a tornare nella stessa stanza per parlare di tubercolosi e di vita. Parlammo di Chopin, il compositore e pianista romantico che contrasse la tubercolosi, e scoprii che quel che li univa non era solo la comune infezione, ma anche l’amore per la musica. Sorrise la prima volta che parlammo di musica e ancora quando parlò della sua famiglia ormai dispersa. Poi, i sorrisi, pian piano svanirono. Capii che la tubercolosi non gli aveva ammalato solo i polmoni, ma anche l’animo. Debole, rinchiuso in isolamento in una stanza di ospedale, cominciò suo malgrado ad accogliere un’insidiosa tristezza. Silenziosamente, passava le serate piangendo. La mattina salutava medici e infermieri con gli occhi gonfi e stanchi. La notte dormiva poco e male, si svegliava sudato, senza sapere se sudasse per via degli incubi o della malattia. Improvvisamente gli mancava tutto: il suo villaggio, la sua lingua, gli abbracci, anche la mamma che non aveva conosciuto. Si chiedeva se si potesse morire di solitudine prima ancora di morire di tubercolosi. Si chiedeva se ci fosse davvero una differenza tra le due. Mi chiesi perché i testi di medicina descrivono solo alcuni sintomi della malattia, come la tosse, la febbre, l’emottisi, ma non dicano mai ‘può causare solitudine e nostalgia’. Mi chiesi se si potesse curare l’infezione senza prendersi cura anche di queste.
Continuai a tornare in quella stanza con storie nuove da raccontare, sperando di lenire almeno la solitudine. Gli raccontai di Chopin, che si era ritrovato in una Maiorca piovosa dove la sua malattia si intensificò, così come la sua produzione musicale. Gli raccontai del preludio scritto a ritmo della goccia d’acqua che cadeva nella camera umida dove il pianista alloggiava. Parlammo di come a volte la malattia possa essere anche un’opportunità, come l’opportunità per Chopin di scrivere il famoso preludio. Forse ispirato dal pianista, il giorno dopo lo trovai seduto sul letto con foglio e penna alla mano, sempre con gli occhi stanchi e gonfi, ma con un’espressione diversa. Disse che non poteva fare molto in ospedale, non poteva leggere nella lingua che non capiva, non aveva nessuno con cui parlare, ma poteva scrivere. Così cominciò a scrivere la storia di un uomo con la tubercolosi approdato in Italia già malato seppure pieno di speranza.
Con il passare dei giorni e gli antitubercolari, la scrittura, pian piano migliorò. Non era guarito, ma non era neanche più contagioso. Fu dimesso un giorno di sole in cui non ero in ospedale. Non riuscii a salutarlo, né a dirgli quanto avevo imparato grazie a lui. Immaginai i fogli scritti stretti in mano. Immaginai i raggi di sole sulle vetrate dell’ospedale dietro di lui. Lo immaginai sorridere mentre respirava a pieni polmoni l’aria fresca che gli era mancata tra quelle pareti. Lo immaginai felice di essere vivo e di aver affidato la sua storia a me – che l’avrei custodita per gli anni a venire.
Torna a tutti i racconti